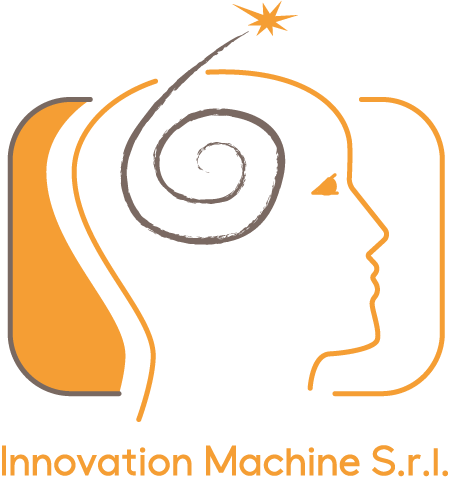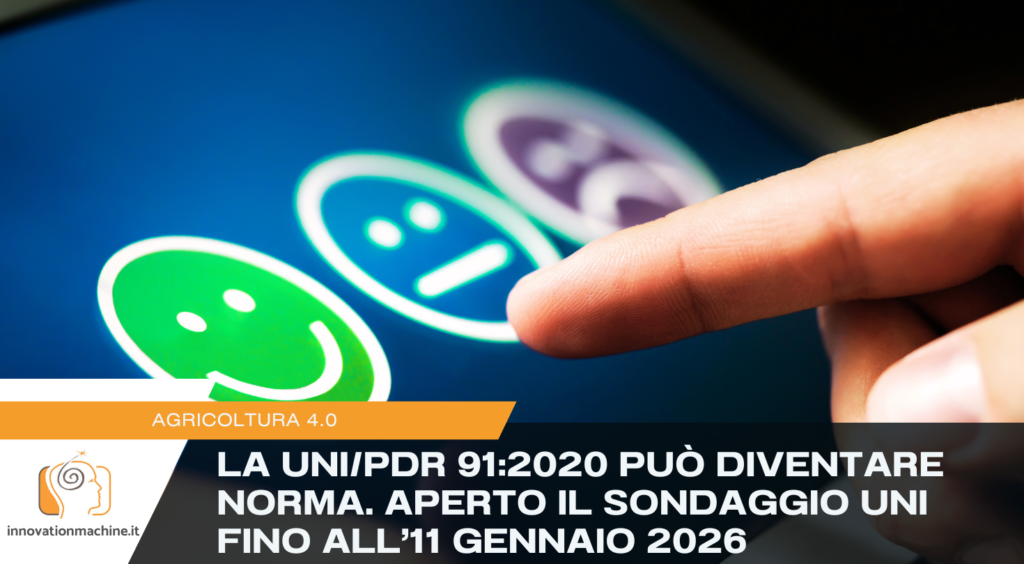Il cuore industriale della Manovra 2026 è rappresentato dalla maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali, una sorta di ritorno al vecchio iperammortamento.
Il requisito centrale resta l’acquisto di un bene 4.0 interconnesso, con riferimento – almeno per ora – agli Allegati A e B della Legge 232/2016, comprensivi delle successive integrazioni. Tuttavia, non è da escludere che nella versione definitiva venga ridefinito l’elenco dei beni agevolabili.
In estrema sintesi di quanto trattato in questo articolo, la misura prevede tre scaglioni di maggiorazione (+180%, +100%, +50%), con un rafforzamento “green” (+220%, +140%, +90%) per gli investimenti che riducono i consumi energetici del 3% sull’intero sito produttivo o del 5% su uno specifico processo.
La misura sostituisce i precedenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0, riportando il beneficio sul piano della deducibilità IRES e introducendo, di fatto, un nuovo paradigma di incentivo legato alla produttività e alla sostenibilità dei processi industriali.
Vediamo quali sono i principali punti di forza e le criticità di questa misura per le imprese manifatturiere, proponendo un confronto con gli strumenti a disposizione delle imprese tedesce.
I pro
Analizziamo quali sono gli aspetti positivi che si possono riscontrare nella bozza della Manovra 2026 in termini di benefici a favore delle nostre imprese rispetto ai precedenti paradigmi.
Aliquote molto generose
Con il rafforzamento “energetico” si arriva a +220% sul primo scaglione (+180% per la parte 4.0 e un ulteriore +40% per la parte “green”), che in pratica equivale a un risparmio fiscale rilevante lungo i cicli di ammortamento. Per il calcolo dell’agevolazione si considera il 24% di IRES applicato alla maggiorazione dell’ammortamento.
Infatti il 24% di 180% è pari al 43,2% di agevolazione.
Neutralità tecnologica (A e B)
Rientrano i classici beni 4.0 materiali e immateriali (Allegati A/B L.232/2016), favorendo sia macchinari sia software/integrazioni e rimettendo quindi in campo anche i software (fondamentali per la digitalizzazione dei processi) e “cancellati” a sorpresa dalla Legge di bilancio 2025 per la 4.0.
Allineamento con efficienza energetica
La condizionalità energetica è coerente con quanto già sperimentato nella Transizione 5.0 (soglie −3%/−5% e ruolo del GSE), segnale di continuità regolatoria.
Semplicità contabile
Incentivo “a monte” (maggior costo deducibile) senza gestione del credito residuo; niente plafond individuali o click-day.
I contro
Beneficio non fruibile in modalità immediata
La maggiorazione dell’ammortamento è una deduzione, non un credito; richiede utili, pena la non fruizione della quota annuale e quindi orizzonte pluriennale. Imprese con redditività bassa/altalenante estraggono meno valore nell’immediato rispetto a un credito d’imposta spendibile subito in compensazione sugli F24.
Beneficio traslato nel tempo
Il beneficio fiscale sarà fruibile soltanto nel successivo periodo di imposta rispetto a quello di acquisizione della perizia o di altro documento che verrà richiesto a testimonianza o garanzia che i requisiti tecnici vengano rispettati (se verrà ripreso il modello di Transizione 4.0/5.0). Pertanto l’appetibilità della misura potrà risultare ridotta per una platea di aziende che invece vorrebbero presumibilmente poter beneficiare prima possibile delle agevolazioni messe a disposizione.
Solo imposte sui redditi
L’extracosto è irrilevante su IRAP; l’effetto complessivo dipende dalla base IRES.
Incertezza su aggiornamento Allegati A/B
Più analisi chiedono un aggiornamento delle tecnologie eleggibili (AI, MES, EMS, ecc.). Se non intervenisse, rischia di non coprire alcune soluzioni oggi cruciali o comunque importanti in fabbrica.
Inoltre negli anni si sono stratificate interpretazioni, interpelli, circolari, FAQ, prassi di riferimento (che anche il Polo Tecnologico Alto Adriatico e membri di Innovation Machine hanno contribuito a redigere), creando un corpus che avrebbe bisogno di razionalizzazione.
Adeguata e Sistematica Reportistica
Se verrà confermato l’onere della cosiddetta “Adeguata e Sistematica Reportistica” (cosa presumibile, in continuità con Transizione 4.0 e 5.0) le aziende per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione (ossia l’intero periodo di ammortamento del bene oggetto di investimento) dovranno raccogliere e conservare dati attestanti il mantenimento dei requisiti tecnici abilitanti l’agevolazione. Quindi significa mediamente dei periodi di 5-10 anni a cui si sommano gli anni in cui l’autorità di verifica potrà chiederne conto, quindi altri 5 anni rispetto alla singola annualità.
Cosa significa per il CFO/COO di un’azienda manifatturiera
Se l’azienda ha utili capienti e una serie di investimenti 4.0 con progetti di efficienza energetica misurabili, la nuova struttura può risultare competitiva. Se invece l’azienda avesse bisogno di liquidità immediata, l’assenza di un credito generalizzato è un limite; potrebbe comunque valutare l’abbinamento leasing + ammortamento maggiorato e, dove possibile, strumenti cumulabili (es. ZES) per ottimizzare il rendimento, per così dire, degli investimenti.
È innegabile che una agevolazione come la maggiorazione dell’ammortamento presenti dei tempi di fruizione più dilatati e per certi versi più macchinosi sia nel calcolo che nella fruizione, rispetto ad un credito di imposta immediatamente fruibile in compensazione.
Se pensiamo a un macchinario con una quota di ammortamento annuo pari al 15%, allora questo macchinario verrà ammortizzato in 7 anni.
Pertanto il 43,2% di beneficio fiscale sarà suddiviso in 7 quote da fruire nei successivi 7 anni a partire dall’annualità successiva alla perizia (sempre presupponendo che continui a venire richiesta).
Se la quota di ammortamento del macchinario fosse del 10% annuo, le tempistiche si allungherebbero a 10 anni.
Questo, comparato ai 3 anni attuali di compensazione del Credito di Imposta per Transizione 4.0 e ai 5 anni di Transizione 5.0, rappresentano un allungamento delle tempistiche di fruizione che sicuramente non agevolano le aziende.
Valutazione e confronto con altre realtà
La misura ci sembra in contro tendenza con analoghe misure, per esempio quelle messe in campo in Germania, che privilegiano il ritorno dell’investimento e la fruizione dell’agevolazione in tempi più stretti e interessanti per le aziende. Vediamo quali sono i punti di confronto.
Il caso Tedesco
Con i necessari distinguo dovuti al diverso tessuto produttivo tedesco e alle diverse dimensioni medie delle aziende tedesche, provando a fare un confronto con la Germania il quadro mostra alcune soluzioni che privilegiano un ritorno più rapido dell’investimento e una maggiore fruibilità dell’agevolazione rispetto a quanto risulta oggi nella bozza della Legge di Bilancio 2026 italiana.
- Il Governo tedesco ha approvato un pacchetto fiscale («Growth Booster – Immediate Tax Investment Programme») che prevede, fra le altre cose, la possibilità per le imprese di dedurre fino al 30% del costo di acquisto di macchinari e attrezzature già nel primo anno, per investimenti fra il 1 luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
- Questo meccanismo genera un effetto liquidità e di “ritorno rapido” dell’investimento: una deduzione o super-ammortamento anticipato consente un alleggerimento immediato della base imponibile.
- Inoltre, la Germania prevede crediti d’imposta e agevolazioni per R&D (ricerca & sviluppo) con tetti più generosi, fino a 25% dei costi R&D, ampliamento della spesa ammissibile da 10 milioni di euro all’anno.
In pratica la Germania punta su fruizione immediata, deduzione anticipata, importi abbastanza consistenti e chiarezza del periodo applicativo.
Il caso italiano
In Italia la misura per l’industria:
- È una maggiorazione dell’ammortamento deducibile (non un vero e proprio credito d’imposta per tutti), quindi il beneficio viene realizzato nel tempo, diluito negli anni (a seconda della vita utile del bene).
- Manca (nella bozza attuale) di un meccanismo di deduzione anticipata molto forte come in Germania (es. 30% immediato del costo) che favorisca la liquidità nel breve termine.
- Presenta il vincolo dell’interconnessione + misurazione dei risparmi energetici, cosa che può aumentare la complessità, mentre in Germania la misura appare progettata per essere “quick start”.
Perché non è del tutto “contro” il paradigma tedesco
- L’Italia integra già il criterio della sostenibilità/efficienza energetica, che è un passo evolutivo rispetto a misure pure di stimolo all’investimento.
- Può essere più adatta a imprese con utili e capacità di investimento strutturate, non solo “liquidità immediata”.
Esempio pratico
Un’azienda acquista un bene strumentale 4.0 da 100.000 €:
- In Italia con la maggiorazione dell’ammortamento al +180%, ne deduce ai fini IRES un valore fiscale di 180.000 €, il che significa un risparmio fiscale in anni multipli, con in definitiva il 43,2% di maggior risparmio ma su diversi anni fiscali.
- In Germania con la deduzione anticipata 30% del costo nel primo anno, lo stesso bene da 100.000 € potrebbe generare una deduzione di 30.000 € immediata, migliorando la liquidità dal primo anno.
Perché il meccanismo previsto dalla manovra 2026 può risultare in “controtendenza”
La misura italiana appare in qualche modo in controtendenza rispetto a un modello che privilegia ritorno rapido e fruibilità elevata, come quello tedesco.
Questo sicuramente risponde all’esigenza italiana di contenimento della spesa pubblica ma penalizza una visione più aggressiva di politica industriale, rispondente alle sollecitazioni e ai tempi rapidi di risposta richiesti dal mercato odierno per continuare a rimanere attivi e recuperare competitività.