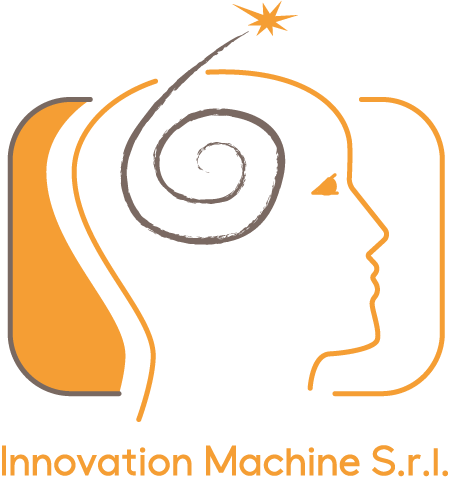Negli ultimi anni l’Italia ha puntato con decisione su politiche di incentivazione per stimolare gli investimenti in tecnologie digitali, automazione e transizione energetica, nell’ambito dei piani Industria 4.0/Transizione 4.0. Queste misure hanno rappresentato un elemento centrale nella strategia di rilancio produttivo post-pandemia e, più recentemente, nel quadro del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Con il progressivo venir meno delle risorse del PNRR e la naturale scadenza di alcune agevolazioni fiscali, emerge però con malcelata evidenza il rischio che l’Italia finisca in una fase di stagnazione tecnologica e produttiva.
In questo contesto, Confindustria ha lanciato un appello al Governo, in particolare al ministro Urso (nelle sue competenze circa industria, imprese e innovazione), affinché la manovra economica 2026 contenga stimoli efficaci per proseguire il percorso di innovazione e evitare un’improvvisa frenata.
In questo articolo analizziamo i rilievi con cui Confindustria interpella il decisore pubblico, il contesto e le implicazioni per l’ecosistema dell’innovazione in Italia.
Confindustria: Transizione 4.0 “si è ripagata da sola”, ma non basta
Un elemento centrale del ragionamento industriale è il dato contenuto nel recente Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria (CSC) di autunno 2025: gli incentivi per investimenti in beni strumentali 4.0, che sono costati circa 20,3 miliardi nel triennio 2020-2022, avrebbero determinato un recupero in gettito fiscale pari al 48,6 % della spesa sostenuta.
In altre parole, quasi metà della spesa pubblica per natura “di sostegno” si sarebbe “ripagata da sola” grazie all’effetto moltiplicatore sull’attività economica. Confindustria evidenzia che questa misura ha favorito una spinta agli investimenti, soprattutto tra le PMI, con incrementi percentuali forti rispetto agli anni precedenti.
Confindustria avverte che l’efficacia del pacchetto Transizione 4.0 non garantisce la sostenibilità futura: con la scadenza programmata di molti incentivi a fine anno e la fine del PNRR, il rischio è che il motore dell’innovazione rallenti bruscamente.
Secondo il CSC, il PNRR apporta un contributo stimato di +0,8 p.p. al PIL nel 2025 e +0,6 p.p. nel 2026; in assenza del PNRR, il PIL sarebbe in contrazione dello 0,3 % nel 2025.
Inoltre, in una visione più estesa, l’analisi degli incentivi per beni strumentali e asset immateriali nel periodo 2016-2024 mostra che su un totale di 74,6 miliardi spesi, il recupero è stato complessivamente del 23,5 %.
Confindustria sostiene quindi che le politiche di stimolo all’innovazione hanno dato risultati significativi — ma che non sono sufficienti a portare l’Italia ai livelli delle altre economie avanzate in termini di investimenti in contenuti tecnologici e digitali. Occorre dare continuità e garanzia nella programmazione.
Le proposte per la manovra 2026 verso Urso e Governo
Alla luce del panorama economico e delle scadenze incombenti, Confindustria formula alcuni spunti operativi da indirizzare al Governo, e in particolare al Ministro Urso, competente in materia d’impresa e innovazione. Ecco i principali richiami:
- Piano triennale per gli investimenti
Confindustria propone che la manovra 2026 non sia un atto isolato, ma che via sia una cornice triennale vincolante di politica industriale, con obiettivi quantitativi e misure programmabili. In questo modo si riduce l’incertezza per le imprese e si configura una visione strategica di medio termine.
- Incentivi strutturali e ricorrenti
Non più misure emergenziali o legate a fondi europei, ma incentivi strutturali alimentati con risorse nazionali, che garantiscano continuità anche dopo l’esaurimento del PNRR. In questo ambito, Confindustria suggerisce di estendere o replicare lo schema della Transizione 4.0, adottando però un orizzonte più stabile.
- Riequilibrio della pressione fiscale sulle imprese più produttive
Una delle criticità oggi è che le aziende con elevata produttività spesso sopportano una quota fiscale relativamente alta. Confindustria propone un riequilibrio della pressione fiscale, al fine di premiare chi investe e produce valore aggiunto.
- Incentivi per Transizione 5.0, efficienza energetica e sostenibilità
Le anticipazioni sulla manovra 2026 suggeriscono che il Governo stia lavorando a una misura che integri digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Il piano “Transizione 5.0” mira a combinare innovazione tecnologica con efficientamento energetico, anche per le imprese energivore finora escluse dai benefici per via del vincolo DNSH.
La sfida qui è strutturare incentivi che superino i limiti attuali: accesso più semplice, tempi più rapidi, finanziamento nazionale e superamento di vincoli Europei che penalizzano settori ad alto assorbimento energetico.
- Integrazione con politiche su innovazione e tecnologia
La prossima manovra non può ignorare le dimensioni emergenti dell’innovazione: tecnologie quantistiche, intelligenza artificiale, digitalizzazione dei processi in settori strategici come automotive, energia, farmaceutico. L’ambiente normativo, la capacità di attrazione di talenti, i meccanismi di partnership pubblico-privato e la sicurezza cibernetica devono essere parte integrante del pacchetto legislativo.
- Mobilitazione della ricchezza finanziaria “parcheggiata”
Confindustria richiama l’attenzione su una ricchezza finanziaria privata che oggi è in gran parte depositata in forme a rendimento zero (conti vincolati, liquidità inattiva). Uno stimolo fiscale (es. incentivi per chi investe parte di queste risorse in imprese) potrebbe disinnescare questo immobilismo.
Fattori critici e rischi da considerare
Nell’ottica di una manovra che ambisca a rafforzare l’innovazione, occorre essere consapevoli anche di elementi di rischio o condizioni che possono mitigare l’efficacia delle politiche:
- Rigidità burocratiche e tempi lunghi: un incentivo è tanto più utile quanto più è semplice da attivare e da rendicontare. Se la burocrazia rimane ostacolo, molte imprese rinunceranno.
- Capacità di assorbimento delle PMI: le imprese di dimensioni minori possono avere difficoltà tecniche o finanziarie a cogliere opportunità di investimento in tecnologie avanzate, se manca supporto (formazione, consulenza, facilitazioni).
- Vincoli europei: misure che dipendono da risorse europee o soggette ai vincoli DNSH rischiano di escludere imprese ad alta intensità energetica.
- Effetto temporale e rischio “interruzione brusca”: se le misure non sono pianificate con continuità, si può avere un effetto “muro” al termine degli incentivi, che scoraggia investimenti futuri.
- Competizione internazionale e rischio di delocalizzazione: Paesi concorrenti stanno rafforzando i loro incentivi per attrarre investimenti high-tech. L’Italia dovrebbe garantire un “ambiente stabile” per non perdere imprese e filiere.
La sfida della continuità e della visione
L’appello di Confindustria a Urso e al governo per la manovra 2026 non va interpretato solo come un elenco di richieste, ma come un’indicazione concreta di ciò che serve per sostenere l’innovazione industriale in un momento delicato. I risultati fin qui ottenuti — come il fatto che la Transizione 4.0 si sia “ripagata da sola” in quasi metà della spesa — dimostrano che gli incentivi possono funzionare se ben calibrati e credibili.
Ma in uno scenario globale incerto, con limiti di bilancio e pressioni internazionali, la vera scommessa è costruire un percorso di lungo periodo: una manovra che sia cerniera di continuità per le imprese, che rafforzi l’ecosistema dell’innovazione e che eviti il rischio recessione tecnologica.
In questo senso, Innovation Machine rimane costantemente aggiornata su tutte le novità che riguardano incentivi, politiche industriali, tecnologie abilitanti e opportunità per le imprese. Continueremo a monitorare le mosse del Governo e a offrire approfondimenti per aiutare le aziende che vogliono cavalcare la transizione digitale e green.